“L’amor che move il sole e l’altre stelle” – l’unica vera prospettiva che permette una analisi relativamente approfondita dell’opera del Sommo Poeta. Le parole chiave di questa indagine letteraria non sono mai troppe: non è un caso se la Divina Commedia fa da paradigma di tutta un’epoca, quella medioevale. Da Boccaccio, con le sue Esposizioni, a Umberto Saba, con Scorciatoie e raccontini, tra l’altro, sono tanti coloro che si sono cimentati nell’impresa di raccontare Dante. E ci son riusciti, chi più, chi meno.
Unico paradigma, dunque, quello divino: la tensione spirituale, il rapporto conflittuale tra cielo e terra, l’irrefrenabile ascesi dello spirito caratterizzano, seppur in modo differente, le tre cantiche, l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. L’immensa fortuna della prima – di alcuni canti, in particolare – ne testimonia la modernità: Paolo e Francesca, in primis. Il V canto, uno tra i più rievocati non solo dai nostri scrittori romantici, è l’emblema di questa continua tensione: Dante è commosso dal racconto di Francesca, la spinge a proseguire, ci regala uno tra i momenti più intensi di tutto il poema:
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
[…]
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Saba tributa grandi onori al canto, facendo riferimento al verso messo in rilievo nel testo, tanto da definirlo uno tra i momenti amorosi più significativi di tutta la letteratura italiana: un momento fatto non solo d’amore, ma anche di passione; quella passione che è uno dei due estremi della predetta tensione dello spirito. Dante si commuove dinanzi al racconto di Francesca, cade “come corpo morto cade”, eppure la storia dei due amanti nutre l’Inferno, non il Paradiso.
La tensione spirituale trova il suo secondo estremo: la virtù. L’Alighieri va oltre i canoni dell’amor cortese, prende le distanze da Cavalcanti: l’amore proposto ha nella virtù, e non nella passione, il suo presupposto. Non tanto nell’obiettivo di Dante, quindi, quanto nel conflitto tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, sta la sua infinita modernità. E non è dir poco per un Trecentista.
Soccombe dinanzi alla virtù tutta una serie di personaggi, Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano, e, in altri canti, Ulisse, “ch’ebbe a divenir del mondo esperto e de li vizi umani e del valore”, e persino Cavalcanti, grande amico del poeta, citato nella Vita Nuova e ufficialmente abbandonato nel canto X dell’Inferno. L’abbandono è emblematico: Dante parla con il padre, un eretico, Cavalcante de’ Cavalcanti. La rottura dell’affetto intellettuale è affidata ai versi 57-63:
e poi che ‘l sospecciar fu tutto spento,
piangendo disse:mio figlio dov’è? E perché non è teco? »
E io a lui:
colui ch’attende là, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno».
piangendo disse:
E io a lui:
colui ch’attende là, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno»
Il poeta rompe con il canone amore-passione, caro a Guido, che tanto “ebbe a disdegno” Colui che conduce il poeta per i cerchi del mondo infernale. La stessa tensione Dante riserva a Virgilio, in uno dei momenti più toccanti di tutto il poema, quando arriva per il fiorentino il momento di abbandonare “colui da cu’tolse lo bello stilo che l’ha fatto onore”. Virgilio, maestro, guida e luce del poeta, lascia il posto a Beatrice: per lui, le porte del Paradiso non si apriranno. Dante dà uno sguardo al passato, piange, ma subito lascia agire la sua amata, figura angelica – e non terrena – che lo invita a proseguire, lo rimprovera degli sbagli commessi, lo spinge a pentirsi:
così dentro una nuvola di fiori
che da le mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fori,
sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.
che da le mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fori,
sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.
[…]
Tosto che ne la vista mi percosse
l’alta virtù che già m’avea trafitto
prima ch’io fuor di püerizia fosse,
volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto,
per dicere a Virgilio
l’alta virtù che già m’avea trafitto
prima ch’io fuor di püerizia fosse,
volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto,
per dicere a Virgilio
[…]
Ma Virgilio n’avea lasciati scemi di sé,
Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’mi;
né quantunque perdeo l’antica matre,
valse a le guance nette di rugiada
che, lacrimando, non tornasser atre.
«Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non pianger ancora;
ché pianger ti conven per altra spada».
Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’mi;
né quantunque perdeo l’antica matre,
valse a le guance nette di rugiada
che, lacrimando, non tornasser atre.
«Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non pianger ancora;
ché pianger ti conven per altra spada».
C’è spazio, insomma, per una amicizia, quell’affetto intellettuale che ha spinto Dante a porre Virgilio come sua guida nell’Inferno e nel Purgatorio (senza tralasciare i motivi letterari di tale scelta: nell’Eneide, Virgilio affronta il viaggio nell’oltretomba), ma tutto si riduce dinanzi all’“amor che move il sole e l’altre stelle”, dinanzi a Colui che è meta di tutto il viaggio, e che rappresenta l’indicibile: il XXXIII canto del Paradiso, l’ultimo di tutta l’opera dantesca, suggella il percorso intrapreso.
Dante non riesce a tradurre in versi la visione di Dio, tutto potrebbe risolversi in un paradossale non-sense, ma così non avviene, anzi in quella non-dicibilità c’è tutto il senso della Commedia, che, sin dai primi momenti del Purgatorio, manifesta tratti di ineffabilità, ancor più decisi nel primo canto del Paradiso:
Nel ciel che più de la sua luce prende
fu’ io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là sù discende;
perché appressando al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.
fu’ io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là sù discende;
perché appressando al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.
Il percorso, insomma, è compiuto: la preghiera di San Bernando alla Vergine anticipa quella visione verso la quale tende tutto il poema, una visione così splendida, così perfetta, e non più perfettibile, da divenire indescrivibile, inafferrabile, non riproducibile, neanche mentalmente:
Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;
ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.
A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che move il sole e l’altre stelle.
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;
ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.
A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che move il sole e l’altre stelle.
L’amore e l’amicizia, dunque, trovano una giusta collocazione nella Commedia – non per niente, il Purgatorio, attraverso il quale Dante ricorda i suoi fratelli, è la cantica dell’amicizia – ne rappresentano gli aspetti fondamentali, ma non esclusivi.
Eppure, tutto fa parte di un disegno ancora più grande, che ogni canto man mano colora, tra tinte piene e sfumature: tutto tende all’infinito, alla virtù che non è solo salvezza. La modernità non sta in questo, chiaramente. Proporre la beatitudine come chiave di lettura moderna è fuorviante, risulta arbitrario e insensato.
È nei contrasti, nella disarmonia, nei moti dello spirito, che si delinea tutta la modernità del poeta. L’immensa fortuna che ha avuto l’Inferno nel Romanticismo, l’attenzione riservata ad alcuni canti, solo accennati sino ad adesso, ne sono la più chiara testimonianza. La Divina Commedia come paradigma moderno, e non solo medioevale, non suona più, dunque, come strana utopia.
Michele Rainone
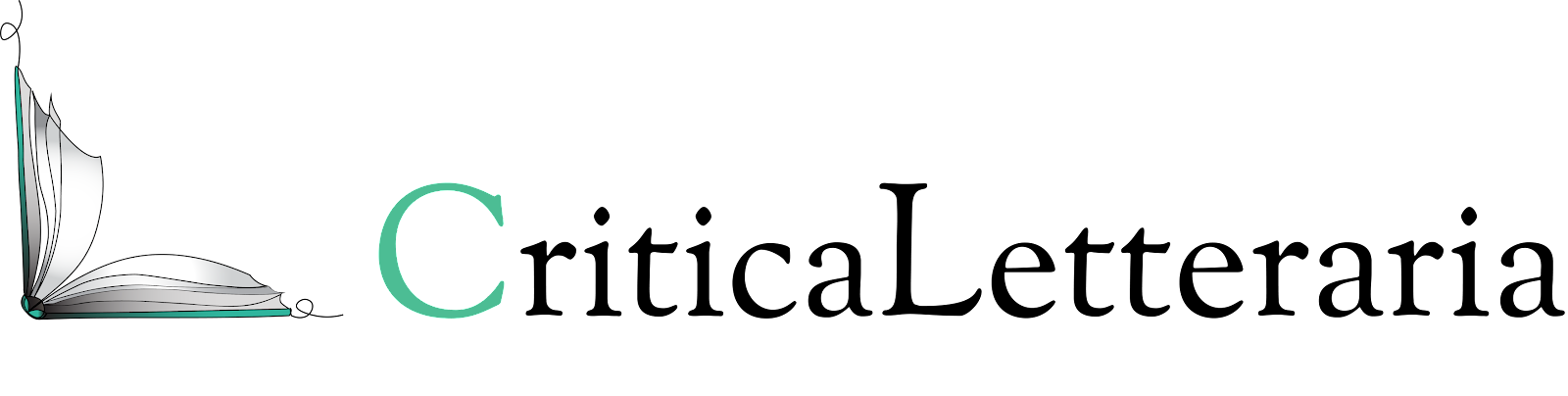




Social Network